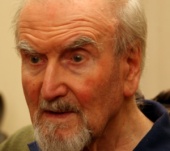Un Nobel per la Brianza
Abbiamo incontrato Eugenio Corti, l’autore de «Il Cavallo Rosso», nella sua casa di Besana: dalla ritirata del Don alla cultura paolotta, passando per gli orrori della guerra.
Ho iniziato a leggere «Il Cavallo Rosso» pochi giorni prima di incontrare Eugenio Corti. Per intervistarlo («Dopo le nove di sera, perché di giorno lavora», mi dice il presidente del Comitato che ha candidato Eugenio Corti al Nobel, Sergio Mandelli) è stato necessario andare a Besana, nella «sua» Brianza. Mentre sono in macchina, penso alle prime pagine del suo libro più importante e mi viene in mente la prefazione di Vittorino Andreoli a un libro lontano anni luce dal «Cavallo» di Corti, «Dracula» di Bram Stoker. Andreoli scrive che quando il lettore ripone il libro in uno scaffale «gli sembra quasi di separarsi da una cosa in cui egli stesso è entrato e se ne può allontanare solo sapendo che il libro è lì ad aspettare e lo si può rileggere in ogni momento.
Se un romanzo ha queste capacità, è un capolavoro e non ha bisogno di altre dimostrazioni.» Lo stesso, penso, vale per «Il Cavallo Rosso.» Merito della storia, dei personaggi, lo ha definito «un affresco impressionante», accostandolo a grandi epopee della letteratura come «Guerra e pace», «I fratelli Karamazov», «Il rosso e il nero.» «È vero, la Francia è un Paese laicista e la critica “che conta”, quella dei grandi giornali, come in Italia, si è sempre opposta ai miei libri. Ma la cultura cattolica francese, pur essendo più emarginata di quella italiana dalla vita pubblica, è forte e non si piega di fronte alla cultura laica. Da noi, invece, la critica cattolica non è neppure presa in considerazione. E poi c’è un’altra differenza: i miei libri in Francia sono stati spinti dalla critica minore, dalle case editrici più piccole, che là contano molto. E, alla fine, anche i grandi giornali, come Le Figaro o Le Monde, si sono accorti delle mie opere.» Undici anni di lavoro, oltre 1.200 pagine («tutte scritte a mano a matita su fogli grandi»), un romanzo densissimo, che intreccia vicende individuali a eventi storici tragici in più di trent’anni, dal 1940 ai primi anni Settanta.
Come ha fatto a trovare un editore disposto a pubblicarglielo? «Andai a Milano da Rusconi con il mio malloppo di 1.500 pagine, ribattute con la macchina da scrivere. Alla Rusconi mi dissero subito che il libro era troppo corposo: “ci costerebbe venti lire a pagina, mi dissero. È fuori mercato. Lei deve trovare un piccolo editore serio. Così passai da Cesare Cavalleri della casa editrice Ares, che pubblicava la rivista Studi Cattolici su cui io avevo scritto alcuni articoli di studio sul comunismo, per chiedergli un consiglio. “Cesare – gli dissi – devo trovarmi un piccolo editore serio per pubblicare il mio libro. E lui, forse per compassione (N.d.r. sorride) mi disse: “Sono io. Te lo pubblico, senza neanche leggerlo…» Cavalleri chiese solo a Corti di «tagliare» un po’ il libro. «Lo rilessi in una ventina di giorni e alla fine riuscii ad eliminare soltanto mezza pagina. Presi il telefono e chiami Cesare: è tutto importante, non posso eliminare niente.» Cavalleri non si perse d’animo e, dopo aver letto il Cavallo, scrisse una lettera a Corti: «Avevi ragione, non devi togliere neppure una parola. Vedrai che arriveremo a fare la seconda edizione.»
E, invece, le edizioni sono 25. «Beh, ero già contento quando Cesare mi scrisse che avrebbe pubblicato il libro e che avremmo fatto una seconda edizione. Però pensavo che, dopo undici anni di lavoro, il “Cavallo” ne meritasse molte di più.» Romanzi, racconti, soggetti per il teatro, saggi e articoli. Tutto ciò che Corti ha scritto in oltre sessant’anni di attività ha trovato dei lettori. Ma quando lei ha cominciato a pensare di poter fare lo scrittore? «Quando, studente di prima ginnasio – l’attuale prima media – al liceo San Carlo di Milano mi trovai tra le mani, senza che il professore ce ne avesse già parlato in classe, l’Iliade di Omero. Fui colpito dal fatto che quell’autore, per me sconosciuto, trasformava in bellezza tutte le cose di cui parlava. Ancora non immaginavo cosa avrei fatto “da grande”, ma ero certo che avrei voluto fare come Omero: scrivere per tradurre tutto in bellezza. E da quell’idea non mi sono più allontanato per tutta la vita.» E, quasi fosse scontato, afferma: «Io sono l’unico erede di Omero.» Altri nomi? «Virgilio e Tolstoj, un grandissimo.» Quando gli chiedo un parere sulla letteratura italiana del Novecento, la sua è una condanna senza appello: «Nella cultura non solo italiana, ma di tutto l’Occidente a metà del Novecento c’è stata una deviazione dalla linea omerica, cioè dalla ricerca della bellezza.
Gli autori italiani di oggi scrivono bene, ma scrivono del nulla. Le loro opere nascono già morte o, quando va bene, moribonde. Ma ciò è accaduto non solo nella letteratura. Anche nell’arte figurativa è così: da Picasso in poi la figura umana, come qualunque altro oggetto, è deformata. L’arte, secondo Aristotele, è l’universale nel particolare. Se lo scrittore o l’artista non racconta l’universale nel particolare, la sua non è opera d’arte.» Omero, Omero e ancora Omero. Ma la «carriera» di Corti inizia nella notte di Natale del 1942, durante la ritirata di Russia. Nei dintorni di Arbusov, la cosiddetta «valle della morte», con temperature tra i 10 e i 45 gradi sotto lo zero, senza cibo, senza un tetto, dove alcuni soldati per disperazione si sparavano, si rivolse alla Madonna («Non un voto, ma un impegno. Ormai non avevo più fiducia nella mia forza di volontà») e decise che, se fosse sopravissuto, avrebbe dedicato la propria vita alla costruzione del Regno di Dio («l’essere umano non può scendere a un livello di odio così bestiale»).
Con una decina di libri in più di sessant’anni tenne fede a quella promessa. Così Corti divenne uno scrittore. Ma il motivo per cui Corti nel Natale del 1942 si trovava nella «valle della morte» ha un nome e un cognome Emmanuel Mounier. «All’Università Cattolica, ero iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, ma di codici e diritto non mi importava nulla. L’unica cosa seria che ho fatto, oltre ad andare a vedere le ragazze di Lettere (N.d.r. sorride), era frequentare la Biblioteca e tenermi aggiornato sulla cultura cattolica mondiale. Un giorno mi capitò tra le mani una copia della rivista Èsprit di Mounier (N.d.r. filosofo cattolico francese, discepolo di Jacques Maritain) e ne rimasi colpito. Mounier diceva che i comunisti non erano degli anticristi, come sostenevano i fascisti in Italia, i nazisti in Germania e i “demoplutocrati in Francia e in Inghilterra. Anzi, i comunisti russi sono più cristiani di noi.» Per Corti erano idee inaccettabili: «Ma come fa a fare questi discorsi sciamannati? Devo andare a vedere!» E così fece. Entrato alla scuola ufficiali di artiglieria di Moncalieri («ero il più bravo in armi e tiro»), è tra i primi dieci allievi su 250.
Può indicare il reparto a cui essere assegnato e sceglie, così, il 30esimo Raggruppamento artiglieria sul fronte russo. Parte per il Donetz nel giugno del 1942. «Al fronte sono stato in mezzo alla gente che abitava nella steppa russa. Tra i miei soldati ce n’era uno, Antonino, un siciliano che aveva imparato il russo alla perfezione. Mi facevo accompagnare da lui e parlavo con i contadini russi: la realtà del comunismo era tragica oltre ogni aspettativa.» Faccio fatica a pensare, guardando il mondo di oggi, ad un ragazzo poco più che ventenne che decide, per una ragione «filosofica», di lasciare la sua casa, l’università, gli amici, la comodità di una vita da figlio di un imprenditore per andare sul fronte russo. Ma Corti, ancora una volta, risponde senza esitazioni: «Non mi sono mai pentito di aver chiesto di andare in Russia. Durante la ritirata mi dicevo: “hai chiesto tu di venire qui! Sarai contento adesso!” (N.d.r. sorride).
Senza quell’esperienza non avrei potuto fare lo scrittore.» Dopo aver visto in faccia il Male come ha fatto a mantenere intatta la sua fede? «Quasi ogni settimana incontro gruppi di giovani e tra loro c’è sempre qualcuno che mi fa questa domanda. La mia risposta è sempre la stessa: nelle situazioni più drammatiche la fede si riconferma. Sono solo un cristiano che ha attraversato tutti gli orrori del secolo scorso e ha aumentato la propria fede. Quando mi troverò al reddere rationem davanti a Domineddio, la mia fede non sarà considerata un merito.» Da quell’esperienza è nato «I più non ritornano», uno dei primi libri sulla disfatta del Don (era il 1947 e lo pubblicò Garzanti, «quando era difficile stampare i libri per mancanza di carta e i giornali erano formati da un solo foglio»), che si affermò subito anche grazie alla recensione favorevole di Mario Apollonio (N.d.r. importante critico e professore di letteratura italiana all’Università Cattolica di Milano, che definì il libro un «romanzopoema- dramma-storia»). «Pensi che “I più non ritornano” è stato tradotto in russo ed è l’unico libro italiano scelto da un’importante casa editrice di San Pietroburgo per una collana dedicata alla guerra russa vista dall’estero.» Poi arrivarono «Il sergente delle nevi» di Mario Rigoni Stern («portato nelle scuole dai comunisti») e «Centomila gavette di ghiaccio» di Giulio Bedeschi («ha incontrato lo spirito della gente»).
Corti ha parlato della disfatta dell’esercito italiano, dei ventotto giorni di marcia nel gelo, dell’orrore, dei morti e dei feriti, «che eravamo costretti ad abbandonare», della mancanza di viveri e munizioni, dell’inverno del 1942 nella «sacca» di Tcherkovo, uno dei momenti più tragici dell’esercito italiano. Oggi, dopo quasi settant’anni, per il sottotenente Corti c’è ancora spazio per il ricordo di quei terribili giorni e per il rimorso. Socchiude per un istante gli occhi e sembra ritornare con la mente nella «valle della morte» quando, accerchiati dai russi che stavano puntando su Arbusov, per un suo ordine non eseguito da un soldato, 200 italiani furono uccisi dai russi. «Avrei potuto avvisarli io e, invece, non sono andato. Mi sono fidato di un soldato che non conoscevo. Che bestialità ho fatto.»
Oggi, a quattro mesi dal traguardo dei novant’anni, portati con fermezza, se non fosse per un leggero tremore, Corti non si ferma. Nella sua casa di Besana legge («non quanto vorrei. Il libro che sto scrivendo sarà l’ultimo, dopo intendo dedicarmi solo a tutti i libri che non sono riuscito a leggere»), prega e, soprattutto, scrive. «Sto lavorando alla quarta edizione, a undici anni dalla prima, de “Il fumo nel tempio”» (N.d.r. un libro dedicato alla profonda crisi del Cattolicesimo che ha seguito il Concilio Vaticano II, che prende il titolo da un famoso discorso di Paolo VI). Sempre con carta e matita, «perché così posso mettere nero su bianco, sul foglio, tutte le correzioni, le cancellature e i cambiamenti necessari, ma per consegnare il libro all’editore adesso uso il computer.» E la candidatura al Nobel? La considera un «risarcimento» per le censure del passato? «No. Se mi dessero il Nobel farebbero solo il loro dovere.» Dopo qualche istante, completa la risposta senza rinunciare a una stoccata polemica: «Sono però convinto che non me lo daranno perché sono uno scrittore cattolico.» Eugenio Corti si alza, aiutandosi con il bastone e ci saluta con una battuta: «oggi non potrei più marciare per 56 ore in mezzo alla neve», dice con un sorriso. L’ultimo pensiero, ancora una volta, è rivolto alla tragedia dell’Armir. E il suo sguardo azzurro sembra passarti attraverso per tornare nella «valle della morte».
Un Nobel a Eugenio Corti
Per sostenere la candidatura di Eugenio Corti al Premio Nobel è possibile inviare un messaggio di posta elettronica al Comitato per l’Assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura ad Eugenio Corti all’indirizzo nobelcorti@aciec.org specificando: nome; cognome; data e luogo di nascita; professione; città e nazione di residenza.
Il Comitato per l’assegnazione del Premio Nobel a Eugenio Corti, presieduto da Sergio Mandelli, è nato su iniziativa dell’ISEB (Istituto di studi economico-sociali della Brianza) e dell’ACIEC (Associazione Culturale Internazionale «Eugenio Corti»).
(09/11/2010 – Walter Todaro – SeregnoInform@)