«Gli ultimi soldati del re»
 «All’inizio del giugno 1944 l’Italia era divisa in due tronconi contrapposti: occupato quello settentrionale dai tedeschi, quello a sud dagli angloamericani. Nel fronte angloamericano – e più precisamente dell’Ottava armata inglese – eravamo inseriti noi ventimila soldati del ‘Corpo italiano di liberazione’ (nome amaro, più speranza di nome che nome)».
«All’inizio del giugno 1944 l’Italia era divisa in due tronconi contrapposti: occupato quello settentrionale dai tedeschi, quello a sud dagli angloamericani. Nel fronte angloamericano – e più precisamente dell’Ottava armata inglese – eravamo inseriti noi ventimila soldati del ‘Corpo italiano di liberazione’ (nome amaro, più speranza di nome che nome)».
È l’esordio de Gli ultimi soldati del re, il romanzo recentemente pubblicato da Eugenio Corti presso le edizioni Ares, che narra le vicende vissute dai nostri soldati dell’esercito regolare tra il 1944 e il 1945, nella guerra combattuta accanto agli Alleati per la liberazione dell’Italia.
L’opera si presenta con lo scopo di dare testimonianza di vicende troppo spesso ‘dimenticate’ (e non senza intenzione) dai resoconti della storia ufficiale.
L’autore, con l’energia e il fascino proprio dei suoi racconti (lo sanno bene i numerosi estimatori delle precedenti opere di Corti, tra le quali occupa un posto di primo piano Il cavallo rosso, giunto, sempre presso le edizioni Ares, alla nona edizione; tradotto in spagnolo e lituano e in corso di traduzione in francese, inglese, giapponese e romeno), conduce il lettore nelle vicende di tanti soldati, i quali hanno speso la vita per mantenersi fedeli a un ideale di patria che la guerra ormai persa non aveva fatto venir meno.
È la storia di un popolo, nella straordinaria varietà dei tipi umani che lo compongono, raccontata con lo stesso stupore con cui il protagonista, sottotenente poco più che ventenne, l’ha vista e vissuta cinquant’anni fa.
Soprattutto, però, è una storia di uomini, con le loro quotidiane brutalità e i loro eroismi, fatta di meschinità e nobiltà d’animo impensate.
Nota costante ne Gli ultimi soldati del re (così come in tutte le opere di Corti) è lo sguardo carico di misericordia con cui l’autore vede e racconta la vita; e insieme è la narrazione lucida e realista di cui Mario Apollonio scrisse: «Per la prima volta, da secoli, fuor degli agguati dello spiritualismo sentimentale, la Fede è fede di cose».
Non c’è astio né polemica, non vi sono tesi da difendere né posizioni predeterminate da assumere a favore o contro le diverse forze che hanno portato a termine la guerra: l’autore noto e amato soprattutto nel mondo cattolico nonostante l’emarginazione a cui è stato costretto dalla cultura laica tiene d’occhio più la storia che la cronaca.
E lo fa in quest’ultima fatica narrativa, che lo vede tra i protagonisti del ritorno a casa di quegli ‘ultimi soldati’ mantenutisi fedeli al proprio giuramento.
«Per tornare a casa sua – scrisse ancora di lui Apollonia – questo Lombardo della seconda guerra […] sceglie il cammin lungo di ritrovare tutta la patria quanto è lunga».
A Eugenio Corti abbiamo chiesto di presentare Gli ultimi soldati del re.
Qual è lo scopo del libro?
Far conoscere la realtà dei soldati della Liberazione. È stata una vicenda completamente diversa da quella partigiana, che pure era parallela alla nostra: anche loro combattevano per allontanare i tedeschi dall’Italia.
Tra i partigiani – occorre ricordarlo – c’erano anche persone che intendevano introdurre – se fosse loro riuscito – una dittatura peggiore di quella che stava andando in rovina.
Vi era, comunque, una differenza fondamentale tra la nostra guerra e quella dei partigiani: noi combattevamo assolutamente senza odio.
Dal principio alla fine noi del Corpo italiano di liberazione ci siamo battuti contro i tedeschi; speravamo di tutto cuore che non ci capitasse di combattere contro i fascisti, cioè contro altri italiani. Diversi fra noi intendevano non sparare, se fosse capitato di trovarci contro delle formazioni italiane (poi ci siamo resi conto che non ve ne sarebbe stata l’occasione).
Un’altra differenza fondamentale era che noi non discutevamo l’autorità legittima: a qualcuno di noi piaceva, ad altri no. Il nostro compito, comunque, era sostenerla: come militari non potevamo fare altro.
L’Italia era in una situazione drammaticissima: bisognava, senza stare a discutere, darsi da fare per venirne a capo.
Dopo la fine della guerra la storia dei partigiani è stata proposta a tutti continuamente, mentre la nostra non è stata presentata a nessuno: a me che l’ho vissuta pareva giusto farla conoscere.
Quali sono i temi principali dell’opera?
La prima grande tematica è d’ordine storico: le vicende accadute in quel periodo nell’Italia del sud. Un’altra è più ‘filosofica’: gli incontri con gli ‘Alleati’, con i partigiani, con la gente e con i nemici; poi gli effetti delle ideologie sulla vita delle persone nella parte centrale del nostro secolo. E ancora: come la fede ci aiuti nel comprendere a fondo e nell’affrontare materialmente la realtà, i guai della vita.
Si sono spente da poco le polemiche intorno alle celebrazioni del 25 aprile: qual è stato il ruolo delle diverse forze in campo nella libérazione dell’Italia?
In occasione dei festeggiamenti dell’ultimo 25 aprile è stato fatto molto chiasso a ricordo della gesta dei partigiani: non mi è capitato una sola volta di sentire in televisione o su un grande giornale qualcuno che parlasse dell’esercito di liberazione. Credo, quindi, che sia giusto cercare di ristabilire la realtà delle cose, anche perché è stato importante il fatto che non solo delle forze partitiche, ma anche forze apolitiche come l’esercito combattessero per la liberazione dell’Italia.
Nella guerra disputata sul nostro suolo il ruolo degli italiani è stato di subordine. La guerra era combattuta tra i tedeschi e gli angloamericani; sia i partigiani che i soldati del Corpo di liberazione hanno influito in parte assolutamente minima. Adesso si è abituati a sentir parlare soprattutto dei partigiani; immagino che molti giovani credano confusamente che a vincere il conflitto siano stati i partigiani: non è vero.
L’importanza dei partigiani non è stata complessivamente superiore a quella del Corpo di liberazione: non c’è stata differenza per quanto riguarda il numero dei partecipanti; le ore di combattimento vero e proprio sostenute dall’esercito sono state senza dubbio più numerose delle loro, così come le perdite, soprattutto se fra le nostre comprendiamo quelle della Divisione Aqui, che si è battuta contro i tedeschi a Cefalonia (in questa Divisione ci sono stati 6/7.000 morti, in prevalenza fucilati). Questo può riuscire sorprendente, ma le cose sono andate realmente così!
Come mai la cronaca dell’immediato dopoguerra e la storia di questo mezzo secolo non hanno riconosciuto meriti all’esercito, mentre le vicende dei partigiani hanno avuto grande fortuna e risalto?
La ragione è che la cultura dominante era della stessa impostazione politica dei partigiani. I soldati si lamentavano per il fatto che si continuasse a parlare dei partigiani e nessuno dicesse niente di noi. Ricordo che più volte ho cercato di convincerli che era meglio così, facendo notare come noi avessimo lottato per la libertà: dopo aver combattuto, ce ne saremmo tornati a casa senza che nessuno di noi ricevesse cariche politiche o amministrative. Questo era il nostro premio: non i posti di assessore o di onorevole, ma la coscienza di aver fatto il nostro dovere e di averlo fatto bene.
Quali erano le motivazioni di Eugenio Corti, giovane sottotenente, durante la guerra nell’esercito regolare?
Come per tutti lo scopo più sentito era togliere l’Italia dalla palude in cui era precipitata, senza stare a polemizzare. Inoltre c’era l’intento di mostrare agli stranieri che, malgrado la sconfitta, eravamo ancora vivi e vitali.
Personalmente, poi, siccome vedo la guerra come un castigo, ritenevo di dover portare anch’io la mia parte del castigo che colpiva tutti.
Lei ha vissuto l’esperienza del fronte russo, anche nei giorni terribili della ritirata in una sacca (così come racconta nel diario «I più non ritornano»), poi ha partecipato alla guerra di liberazione: c’era uno spirito diverso tra il combattere sul suolo della propria patria e il combattere in terra straniera?
La situazione della guerra in Russia era molto diversa da quella in Italia: qui le singole ore erano meno legate alla sofferenza, Innanzitutto non c’era il problema del freddo, noi non abbiamo sperimentato la fame (come è accaduto, in modo tremendo, in Russia); questa era una guerra meno spietata.
Certo, nel caso in cui fossimo caduti prigionieri, non eravamo sicuri di avere salva la vita, perché non si sapeva bene come ci avrebbero trattato i tedeschi; tuttavia nella guerra in Italia non si sono verificati gli episodi di ferocia e abominio che abbiamo visto in Russia. Insomma, eravamo decisamente più sereni, sebbene anche qui ci fosse il pericolo di lasciarci la pelle.
Personalmente avevo chiesto di essere destinato in Russia per farmi un’idea di che cosa avesse portato il tentativo di costruire un mondo completamente svincolato da Dio, anzi, contro Dio: soprattutto questa era la tensione che occupava il mio pensiero al fronte russo. Nella guerra in Italia, invece, mi muoveva un senso di espiazione: dovevamo scontare davanti a Dio le colpe di noi tutti. Inoltre mi interessava anche conoscere i popoli diversi con cui siamo venuti a contatto: innanzitutto i polacchi, poi gli inglesi, gli americani, gli indiani.
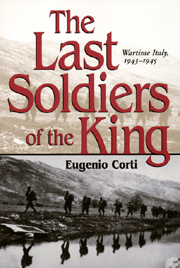 Nel romanzo compare una figura che ha avuto una parte notevole nella guerra di liberazione, e che è molto legata all’Università cattolica…
Nel romanzo compare una figura che ha avuto una parte notevole nella guerra di liberazione, e che è molto legata all’Università cattolica…
Si tratta del vicentino Giuseppe Cederle, nato nel 1918, studente di Lettere alla Cattolica di Milano nel periodo in cui anch’io frequentavo questa Università; non ho avuto occasione di conoscerlo, perché ero iscritto a Giurisprudenza.
Ho sentito molto parlare di lui nel Campo di riordinamento di Guagnano (Lecce), uno dei luoghi in cui, dopo l’armistizio, venivano raccolti soldati sbandati di diverse provenienze.
Io ho raggiunto i reparti combattenti nell’Epifania del ’44; tutti parlavano di Cederle, caduto nella battaglia di Montelungo l’8 dicembre ’43, perché, nell’ambito relativamente ridotto della prima Unità che ha combattuto contro i tedeschi (il primo Raggruppamento motorizzato), era stato il maggior trascinatore: per ragioni religiose aveva condotto al fronte tutti gli allievi di una Scuola ufficiali. In seguito ho cercato di documentarmi sulla sua figura attraverso le pubblicazioni dell’esercito: ne sono rimasto affascinato.
Cederle aveva la convinzione di essere destinato da Dio a una precisa missione, ma non sapeva quale fosse: evidentemente era quella di partecipare al recupero dell’Italia dalla palude. Adesso il suo nome è allineato con gli altri nella lapide che ricorda i ragazzi Pro patria mortui, nel secondo chiostro dell’Università cattolica di Milano; accanto al nome c’è la sigla M.O.V. M. (Medaglia d’Oro al Valot Militare).
Agli inizi degli anni ’70, parlando con il Rettore Lazzati, gli ho più volte proposto di presentare agli studenti la memoria di Giuseppe Cederle. che, a mio avviso, era una figura esemplare non meno di Cesare Battisti o di Silvio Pellico. Ancora oggi penso che potrebbe essere un’ottima cosa proporre all’attenzione dei giovani la sua storia. Lazzati, tuttavia, mentre era apertissimo a individuare tanti aspetti della realtà, era chiuso a tutto ciò che avesse rapporto con la guerra. Egli aveva trascorso un anno e mezzo di prigionia in Germania con gli alpini, ma della prigionia non voleva parlare. Io credo valga la pena di riconoscere negli alpini lo straordinario spirito del soldato cristiano, come ha ben messo in luce don Carlo Gnocchi.
Tra i protagonisti del romanzo una parte notevole occupano i soldati: quali aspetti del loro modo di essere l’hanno colpita?
Nei soldati del Corpo di liberazione, che erano in grande maggioranza del nord, e dunque, di regioni occupate dai tedeschi , uno dei moventi principali per cui combattere era aprirsi la strada per tornare a casa, per raggiungere la loro famiglia. Tra questi soldati si verificavano regolarmente le diversità di comportamente presenti nell’esercito in generale: c’erano i paracadutisti, straordinariamente prestanti dal punto di vista del valor militare per il loro coraggio (anche incosciente, talvolta); molto valorosi erano anche gli alpini, i quali avevano caratteristiche di tenuta, oltre che di assalto; i bersaglieri, validi assaltatoti, anche se non così efficaci come i paracadutisti; gli arditi del Battaglione Boschetti, assaltatori anche migliori dei paracadutisti.
C’erano, poi, le truppe ordinarie, della quali facevo parte, che erano tendenzialmente poco efficienti, con gradazioni diverse; certamente eravamo meno efficienti dei tedeschi contro i quali combattevamo. Credo che questa fosse anche la realtà delle formazioni partigiane, ad eccezione di quelle che comprendevano un numero molto elevato di alpini: in quel caso le formazioni partigiane erano straordinariamente efficienti, come i reparti alpini ordinari.
Ne «Gli ultimi soldati del re» ritorna continuamente il tema dell’amore, strettamente legato alle diverse figure di donna, tutte riconducibili alla protagonista Margherita: qual è il senso della presenza femminile in un’opera che è soprattutto di guerra?
Al soldato si addice la donna, più come presenza nel cuore che come presenza fisica: il richiamo, quindi, sorge spontaneo. Nel romanzo si vede come io, ventitreenne, tendevo a entusiasmarmi appena incontravo una donna un po’ fuori della norma.
La protagonista Margherita rappresenta l’amor dell’amore: senza conoscerla veramente tendevo a innamorarmene. È persona reale, che ho ripreso anche nel mio precedente romanzo, Il cavallo rosso, con il nome di Colomba. Molto significativa è pure la figura di Giulia, la ragazza che ho incontrato il giorno della nostra entrata in Chieti: rende bene l’idea dello stato d’animo del soldato, anche di quello cristiano, rispetto alla donna. Giulia era giovanissima, di una semplicità straordinaria (com’erano gli abruzzesi di allora), dotata di una: femminilità antica, della quale era inconsapevole.
Poi c’è Lina, la maestrina di campagna della zona di Teramo, che richiamava in modo straordinario le Madonne dei pittori medioevali: era la figura incantevole della donna italica. E ancora Anna, la bella ragazza più navigata, del beneventano; il fatto che io stesso, nei rapporti con lei, non tendevo a difendermi ma mi lasciavo incantare, mi faceva venire bene in mente quale dovesse essere stata l’idea del vecchio Omero nel tracciare la figura di Circe, con quell’incantamento da cui gli uomini venivano ridotti in porcellini.
Nel romanzo si cammina molto: è questa, forse, la tematica sottesa a tutta l’opera. C’è un valore simbolico-letterario nella scelta del tema del viaggio?
La concezione cristiana della vita ci ricorda che il peregrinare (lo scarpinare, come dicevamo noi soldati) è parte essenziale della condizione dell’uomo: ogni arrivo è un adombramento dell’unico arrivo vero, quello definitivo che conclude l’esistenza.
Il vostro cammino di soldati è stato volto a recuperare, nella concretezza del mettere un passo dietro l’altro, il senso di un’unità nazionale che, da qualche tempo a questa parte, è di fatto messa in crisi: ma allora, il vostro sacrificio è stato inutile?
La nostra vicenda è ormai molto lontana e, dunque, è stata dimenticata. Nel dopoguerra i soldati sono stati considerati degli stupidi da gran parte della popolazione, perché la motivazione principale per cui agivano era il loro senso del dovere, su cui i ‘furbi’ ironizzavano.
In seguito si è visto come si è ridotta l’Italia in mano ai ‘furbi’: anziché rispettare il denaro su cui potevano mettere le mani, i ‘furbi’ hanno messo le mani su quel denaro, e a poco a poco si è giunti alla situazione che tutti conosciamo, di gravissima crisi morale. Questa è, in un certo senso, la rivincita dei soldati, la vittoria postuma di quanti avevano il senso del dovere.
I discorsi che sostengono ipotesi di secessionismo, poi, non mi preoccupano affatto: provengono da una minima parte dei leghisti, i quali rappresen’- tano in tutto l’8% della nazione; sono irrilevanti, come lo erano quelli dei separatisti siciliani alla fine della guerra.
Lei parla spesso, nelle sue opere, di patria, come qualcosa per cui valga la pena di impegnare la giovinezza, la vita: crede che questo sia un valore ancora proponibile ai giovani? E che cos’è, per lei, la patria?
La patria è, innanzitutto, l’eredità !asciataci dai padri, da nostro padre (non la retorica della patria che ci aveva bombardato durante il fascismo!): sono le persone vicine a noi, i nostri familiari, gli amici, la casa in cui abitiamo. Soprattutto la patria è il nostro mondo, diverso da tutti gli altri; ce ne rendiamo conto quando incontriamo gli stranieri, vedendo la diversità tra il nostro e il loro modo di essere. È per questa patria che vale la pena di darsi da fare.
È un ideale che, dopo la guerra, si è perso, perché ha vinto una cultura, quella di stampo illuminista, la quale è contro le patrie ed è funzionale all’ideologia che pretende di risolvere tutti i problemi dell’uomo. Secondo quest’ideologia l’uomo sarebbe figlio del mondo, non apparterrebbe al proprio tempo ma ad ogni tempo.
Qual è, nella situazione di crisi morale a cui ha accennato, il compito dei cattolici, soprattutto in merito al recupero del senso della patria?
Oggi ci sono tra noi molti falsi maestri, anche in buona fede, che non si rendono conto del guasto che fanno: i cattolici hanno la responsabilità di portare i falsi maestri a correggersi.
Pensiamo, ad esempio, ai cattocomunisti i quali, pensando di essere originali, hanno seguito i comunisti nelle loro posizioni contro la patria, anche per quanto riguarda l’obiezione di coscienza. I cristiani dovrebbero richiamarsi a quanto diceva don Carlo Gnocchi (è stato cappellano degli alpini sul fronte russo): egli dava grande importanza alla realtà del soldato che, al fronte, è alter Christus, perché dà la vita per gli altri, anche per quelli che lo detestano.
Anche se oggi sembra un’eventualità lontana, il soldato si prepara per combattere; pochi riescono a capire l’importanza del servizio militare, e questi sono soprattutto fra gli alpini, che applicano lo spirito di servizio a diversi ambiti.
Il suo romanzo si apre con una dedica-invocazione a Maria: perché questa scelta?
Inizialmente il libro è stato proposto a un grande editore, che lo avrebbe pubblicato a condizione che eliminassi la dedica alla Madonna. Ho rifiutato perché a me, che sono un narratore, anzi, un cantastorie cristiano, viene spontaneo iniziare il mio cantare rivolgendomi alla Madonna, come gli antichi poeti si rivolgevano alla musa.
Credo, inoltre, che nessuna storia umana, soprattutto se è storia di prove e sofferenze, possa essere raccontata senza un richiamo di partenza alla Madre misericordiosa.
La chiusa è forse tra le parti più inquietanti e coinvolgenti de Gli ultimi soldati del re; in essa si parla della percezione dello Spirito che non lascia scampo alla vita di ogni uomo: che cosa ha significato, nella sua vita, operare secondo lo Spirito?
Subito dopo la fine della guerra al fronte si apriva quella politica che a me ripugnava moltissimo, soprattutto quando era politica di piazza: e lì non c’era scampo, occorreva ancora darsi da fare. In generale, comunque, si tratta di intendere la vita come milizia: mi sono sempre sentito impegnato a combattere per l’avvento del Regno, attraverso il mestiere di scrittore.
Ho cercato di combattere quella che un tempo si chiamava ‘la buona battaglia, pur sapendo che questo avrebbe comportato un’emarginazione da parte della cultura dominante: è l’esclusione a cui mi sono trovato di fronte nella mia vita, anche se le mie opere hanno comunque avuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico.
Quali sono i fondamenti estetici della sua narrativa?
Quando scrivo ho forte la sensazione dello Spirito che “Soffia dove vuole”: nell’ordine soprannaturale a cui fa riferimento il Vangelo si tratta dello Spirito di Dio; tuttavia anche nell’ordine naturale, nel lavoro all’opera d’arte c’è una proiezione di questo spirito. Già gli autori antichi avevano tale percezione, tant’è vero che si richiamavano continuamente alla musa.
Per me l’opera letteraria è paragonabile ad un arco che si sostiene su due colonne: la verità e la bellezza. Se una di queste colonne viene meno, l’opera entra in crisi. L’arte è per la vita: non si scrive per il gusto di scrivere o soltanto perché chi legge provi piacere, ma si deve avere come fine ultimo il Bene. Naturalmente anche l’appagamento estetico è fondamentale.
Per il romanziere le vie poetiche da percorrere devono essere tutte quelle possibili: nel romanzo deve esserci il dramma, la lirica, la tragedia, l’epica (il genere che sento più vicino), la satira, l’umorismo (ineludibile, nel nostro tempo).
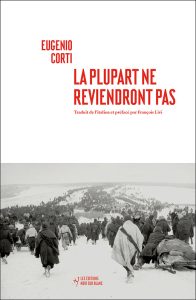 Per gentile concessione dell’editore pubblichiamo un episodio de Gli ultimi soldati del re.
Per gentile concessione dell’editore pubblichiamo un episodio de Gli ultimi soldati del re.
Ogni tanto, infangando indecentemente le scarpe inglesi nuove, andavo a trovare i due Antonio a San Lorenzello, un paesino a valle di Cerreto Sannita. Qui Antonio Moroni aveva (”Guarda, guarda, si ripete il miracolo!”) suscitato l’amore della padroncina di casa. Però non lo contraccambiava.
«Vedi?» commentava Castelli: «Quanti altri, oggi, non farebbero la corte a quella ragazza! È chiaro che c’è qualcosa che non funziona, o funziona a rovescio, nel meccanismo di questo mondo.»
«Eccoti una riprova» io gli dicevo, «che la vita definitiva non è questa. Eccoti qui un’ennesima riprova, caro il mio agnostico militarizzato. Ma basta, questo è un tempo in cui non sono portato a predicare.»
«Intanto però predichi» mi faceva notare lui.
«Cosa ti succede? Non sarai giù di giri soltanto perché ti hanno scacciato anche dal Secondo gruppo?» diceva Moroni.
«Tu ormai a essere scacciato dai gruppi dovresti averci fatta l’abitudine.»
«Infatti non è questo che mi deprime, ma la vostra compagnia, il semplice fatto di trovarmi con voi.» Tornavo magari a considerare Castelli: «Certo che, dopo tutto quello che abbiamo visto, per conservarti non credente ti ci vuole una bella faccia!»
Lui alzava con insofferenza gli occhi al cielo, borbottava: «Piantala con le tue scemenze, per favore. Falla finita.»
Io invece andavo avanti: «L’onore e il dovere… Tu su quelli ci costruisci la vita, ogni tua azione. Già. Però spiegami: se Dio non esiste, che significato possono avere l’onore e il dovere? Uno, oggi, può ritenere onorevole, e suo stretto dovere, macellare il prossimo: come Hitler, e Stalin, e i milioni e milioni che li seguono». Concludevo alzando un po’ la voce:
«È o non è così?»
Castelli mi guardava per qualche istante con occhi duri; poi ricordava d ‘essermi amico, sbuffava, lasciava perdere.
«Basta. Potrai tirare avanti quanto vuoi» io allora rincaravo, «ma non hai scampo: ti sei trovato Dio di fronte, per forza dovrai credergli»
«Fa l’ometto» sbottava allora lui, «astieniti almeno dalle predizioni. Sai quanto danno ai nervi.»
Mentre così disquisivamo di teologia, capitava entrasse nel locale la padroncina di casa. Aveva, pur essendo meridionale, la pelle chiara e i capelli di un biondo quasi diafano, tanto da richiamare l’idea di un tenue acquerello. Qualche volta ci portava attraenti porzioni di pollo su piccoli piatti, esoticamente. Sedeva però sempre un poco in disparte, non accettava di mangiare con noi.
«Susanna» le diceva Castelli mangiando di gusto, «il tuo pollo disossato sì è convincente.»
«Abile e arruolabile» convenivo anch’io, facendo lo spiritoso col rozzo frasario dei soldati. Colei in realtà non si chiamava Susanna; immagino Castelli la chiamasse così per sdrammatizzare: aveva recuperato per lei il nome dell’oca portafortuna, finita da un pezzo mangiata dai paracadutisti.
«Grazie» ci rispondeva sorridendo con indulgenza Susanna.
«Meno male che qui ci sei anche tu, a ricordarci che nel mondo esistono ancora le maniere civili» le diceva molto a proposito Moroni. Susanna sorrideva di nuovo, e dopo un po’, quando la convenienza glielo consentiva, se ne andava; paga forse d’avere, in vicinanza di Antonio Moroni, raccolta una sua piccola messe, nota a lei sola, di cose su cui fantasticare.
Nel locale delle disquisizioni teologiche le succedeva talvolta, appoggiandosi a un lungo bastone, un vecchissimo prete tutto pillacchere e sdruciture, al quale, con discrezione, i miei due amici facevano prontamente portare una gavetta di rancio. Ch’egli mangiava con straordinaria voracità, conversando in pari tempo, per quanto poteva, con noi.
In pensione da molti anni, il vecchio viveva di fame con un’annosa nipote presso una chiesuola sconsacrata in mezzo alla campagna. «lo sono canonico del duomo di Cerreto» mi avvertiva ogni volta, quasi ciò rimettesse ogni cosa a posto. Parlava sempre a voce molto alta, perché sordo. Scopo delle sue visite erano quel po’ di rancio, e un cappotto militare ancora in buono stato, che Moroni gli aveva promesso non appena si fosse reso disponibile.
Del cappotto il vecchio parlava scopertamente, con straordinaria compiacenza; se lo sognava addirittura ad alta voce: «Lo tingerò di nero» diceva, «e mi andrà bene, proprio bene.» In quei momenti i suoi gesti e la voce si facevano simili a quelli con cui gli altri napoletani parlano di una donna.
A parte quei momenti usava, trattando con noi (ufficiali: dunque – secondo lui – persone colte) un tono di colleganza compiaciuta, per quel po’ di latino che gli era rimasto nella memoria. Ad aumentare i punti di contatto ci descrisse anche, e non una volta sola, una lite che aveva sostenuto con i tedeschi. Nella loro tranquilla ferocia quelli avevano accatastato dentro la chiesuola sconsacrata e contro le mura esterne della sua abitazione, lontano dai paesi, un grosso deposito di mine. Ciò egli aveva per necessita tollerato; ma quando un sergente e due soldati avevano preteso d’entrargli in casa per ispezionarla, non l’aveva consentito. Da una finestra sovrastante l’entrata, li aveva sgridati con parole veementi, che ora ci ripeteva, riempiendo di grida napoletane il locale, finché – non si capiva se apposta o incidentemente – aveva fatto cadere sulla testa del suo principale interlocutore un vaso di gerani. Il tedesco n’era rimasto intontito («stunato»), tanto che i suoi due camerati avevano dovuto sorreggerlo, mentre il vecchio agitando alto il bastone – come faceva ora nel rievocare – «Sargé… Sargé…» gli aveva gridato «lasciami in pace, o ti farò provare anche questo. Vattènne sargé…»
«E u sargente» concludeva il vecchio «senza dicere ‘na parola se n’è juto». Alla fine anch’egli, zoppicando e tutto miseria se ne andava, scuotendo la testa con qualche brontolio residuo. Dopo di che io tornavo, infangando di nuovo indecentemente le scarpe inglesi, nel mio alpestre paese.
(Paola Scaglione, giugno 1994, Vita e Pensiero)
