Un episodio del cavallo rosso commentato da Andrea Sciffo
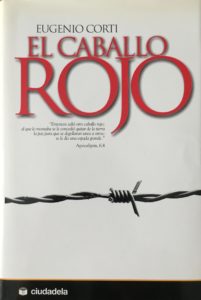 Il romanzo maggiore di Eugenio Corti possiede le due caratteristiche di una vera opera d’arte: primo, è il testo stesso nella sua bellezza che si pone a giudicare il lettore, dato che lo attira o lo allontana dai propri tesori (io, rileggendolo per quest’occasione, l’ho trovato travolgente). Secondo, pur essendo Il cavallo rosso una narrazione realistica di guerra e di storia militare, in esso prevalgono alcune scene di uomini che muoiono non perché vengano uccisi (cosa ovvia), ma perché “incontrano la propria morte”: fatto più unico che raro per noi che siamo costretti a vivere un’epoca in cui letteratura e cinema riproducono morbosamente l’omicidio e l’assassinio.
Il romanzo maggiore di Eugenio Corti possiede le due caratteristiche di una vera opera d’arte: primo, è il testo stesso nella sua bellezza che si pone a giudicare il lettore, dato che lo attira o lo allontana dai propri tesori (io, rileggendolo per quest’occasione, l’ho trovato travolgente). Secondo, pur essendo Il cavallo rosso una narrazione realistica di guerra e di storia militare, in esso prevalgono alcune scene di uomini che muoiono non perché vengano uccisi (cosa ovvia), ma perché “incontrano la propria morte”: fatto più unico che raro per noi che siamo costretti a vivere un’epoca in cui letteratura e cinema riproducono morbosamente l’omicidio e l’assassinio.
Tutta un’altra cosa con Corti, che è scrittore paragonabile a un Aleksandr Solženicyn o a un Vassilij Grossman; infatti, è impossibile non fremere di commozione e di dolore leggendo la sequenza che conduce alla morte del bersagliere Stefano Giovenzana sul fronte russo (pagg. 317-324): era il 20 dicembre 1942, e il giovane contadino brianzolo proiettato nella guerra delle truppe italo-tedesche contro i sovietici trovò la morte durante uno scontro a fuoco, in mezzo alla pianura ghiacciata presso il fiume Don, nello scenario livido di una battaglia di fanteria. Il personaggio si trovava in una situazione disperata, senza via d’uscita, con al fianco un solo commilitone, per di più sconosciuto, accerchiati dai nemici, e avendolo capito: “non per questo però accettavano di morire” (p.319).
Il lettore (cioè, io) è qui assalito da un’angoscia senza limite: quella di essere braccato e di terminare i propri giorni tra estranei, sperduti. Appare la nota dominante della narrativa cortiana: la realtà quotidiana appare anche come un destino, ed è famigliare ed estranea nello stesso momento: per questo, il suo è un romanzo cristiano. Ma il capolavoro di finezza esce dalle mani di Corti romanziere quando deve descrivere l’atto della morte: colpito da una sventagliata di pallottole, Stefano si sforza “di reprimere la propria orribile agitazione”, poi chiude gli occhi, e gli appare sua madre “seduta lì, nella cucina di casa, al solito posto: la mamma dalla sedia lo guardava” (p.322).
Chi si diletta di letteratura noir o gialla o horror, difficilmente accetta di abbassare le difese, e di lasciarsi conoscere: vuole libri umani, troppo umani. Del resto, in quel genere narrativo il titolo maggiore è “Io uccido” di G.Faletti. Qui no, il motto è “io muoio” e lo sento, e misteriosamente acconsento. Non ci sono eccidii, stragi, compiacimenti da macello: la guerra come la racconta Corti (assai diversamente dal suo coetaneo Mario Rigoni Stern) il sangue è versato, certo orribilmente, ma è un peccato al cospetto di Dio, un gesto gravissimo che però non grida alcun rancore dal suolo bagnato e cruento. Semplicemente, il respiro di chi muore termina, e attende sperando un altro tempo. Rimando perciò alla lettura diretta del brano qui accanto, per cogliere in diretta la perfezione della composizione della pagina: l’invocazione del giovane morente (semplicissima: “Mamma! Mamma”, l’incolore presenza del compagno d’armi che viene persino confuso con un compagno di giochi dell’infanzia, e il finale tentativo di respingere la morte fisica; con quella di Stefano, difatti, siamo di fronte a una morte benedetta perché è dapprima respinta (nel Getsemani, Gesù chiede di “passare questo calice”), poi subita (il proiettile gli entra come “un urto, un pugno in pieno petto”), infine lasciata passare: “La sua anima abbandonò il corpo. Come quando bambino, nel cortile della Nomanella, poggiati per gioco le mani e il ventre su una stanga del carro, Stefano spingeva le gambe in alto e la testa in giù per vedere il mondo capovolto, così ora intorno a lui si produsse un grande capovolgimento. Nello stesso istante a Nomana –a tremila chilometri di distanza- un ticchettio su un vetro della camera da letto destò la mamm Lusìa, che lanciò un grido: Stefano è morto! Oh, povera me, povera me, povera me.” (p.323).
Nel mondo reale, descritto da Corti, gli uomini che amano comunicano a distanza misteriosamente, aiutati in ciò dallo Spirito Santo e dai loro Angeli Custodi, che nella narrativa cortiana rivestono un ruolo estremamente discreto e potente e personale, celeste, come gli occhi dello scrittore di Besana Brianza e il cielo delle grandi pianure europee scenario di guerra: gli angeli si annunciano sulla soglia della vita con un fruscio di ali e, dopo la morte, fanno vedere il proprio volto, come nel Purgatorio dantesco. Qui però andrebbe aperto un altro discorso, attinente alla morte di un altro personaggio del romanzo, il tenente Manno, il 7 dicembre del 1943 presso Montecassino, oppure relativo al finale del libro e all’aura azzurra dell’ultima pagina decisiva. Ma lo faremo in un altro momento.
Resta solo da dire che ne Il cavallo rosso la morte non è un “fatto” bensì un “atto”: è un istante limpido, brevissimo, alla fine di sequenze livide e tremende ma che tuttavia si fermano lì, non possono andare oltre. Quel passaggio è anche una porta aperta, fuori dalla quale rimangono l’autore e i lettori, ma che dà l’impressione di condurre da qualche parte; in Italia, nessuno nel Novecento ha mai scritto così: in Russia ci sono stati i grandi artisti vittime della repressione comunista (ai già citati Solženicyn e Grossman aggiungiamo Pavel A. Florenskij e Varlam Šalamov), nell’area anglosassone c’è stato J.R.R. Tolkien, autore di un romanzo analogo a quelli di cui si tratta e anch’esso vittima della repressione (della Critica letteraria, stavolta).
Del libro di Eugenio Corti difficilmente si farà un film: ed è meglio così. Forse è impossibile, come per la Divina Commedia, perché l’immaginazione spirituale è fatta di istanti limpidi adatti solo all’animo del lettore, non alla pellicola di una cinepresa.
(Andrea Sciffo, 26/07/10, Il Cittadino MB)
