Il senso dell’uomo e della storia nell’opera di Eugenio Corti
 Quando considerava la propria vocazione letteraria, Eugenio Corti ne individuava il passaggio decisivo in un episodio accaduto durante la ritirata di Russia. Proprio in uno tra i momenti più drammatici di quella vicenda, infatti, la sua intuizione di essere chiamato al compito di scrittore assume la forma consapevole e definitiva di una chiamata a cui consacrare l’intera esistenza.
Quando considerava la propria vocazione letteraria, Eugenio Corti ne individuava il passaggio decisivo in un episodio accaduto durante la ritirata di Russia. Proprio in uno tra i momenti più drammatici di quella vicenda, infatti, la sua intuizione di essere chiamato al compito di scrittore assume la forma consapevole e definitiva di una chiamata a cui consacrare l’intera esistenza.
Era la notte di Natale del 1942 e per lui, giovane ufficiale di artiglieria dell’Armata Italiana in Russia, la ritirata era iniziata il 19 dicembre, quando, dopo tre giorni di battaglie furibonde seguite a un’offensiva russa sul fronte del Don, era arrivato l’ordine di ripiegare, abbandonando le postazioni e tutti i materiali.
In quella notte Eugenio, che non ha ancora compiuto ventidue anni, come molti altri soldati è nel pieno di una marcia ininterrotta nel gelo (la temperatura media è di 20-30° sotto zero e una notte il termometro tocca -47°), senza viveri né munizioni, con la prospettiva di morire o, peggio, di finire prigioniero dei russi, dalle mani dei quali si diceva che nessun nemico fosse mai uscito vivo. Assediati nella vallata di Arbusov (la «Valle della morte», nella memoria dei reduci), Corti e i suoi compagni hanno la sensazione che la fine sia imminente. La necessità più immediata è quella di continuare a muoversi per sfuggire alla morsa di un freddo intensissimo, che costella i bordi della pista battuta dai soldati di mucchietti di carne e stracci congelati, resti senza vita di quello che era stato un esercito.
La situazione, a viste umane priva di scampo, induce ancora una volta Eugenio ad affidarsi a Maria, come gli aveva insegnato a fare sua madre. Racconta nel diario I più non ritornano: «Feci alla Madonna una promessa […] che avrebbe informata tutta la mia vita futura, se mai m’avesse concesso il ritorno alla mia casa. Ed è anche per mantenere questa promessa che mi son deciso a pubblicare queste memorie» (Eugenio Corti, I più non ritornano, Garzanti, Milano 1947, p. 126).
Il riferimento metaletterario si rivela decisivo per chiarire il fine che Corti attribuisce alla propria scrittura, nel quadro di quell’indissolubile unità tra vita e letteratura che è elemento determinante nel suo percorso biografico e nella sua riflessione. In tale dimensione, il valore della circostanza vissuta si rivela nella prospettiva della trascendenza e la pagina scritta, nel suo compito di chiarificazione e di testimonianza, ne assume la portata.
In seguito lo scrittore avrebbe spiegato di aver deciso, in quell’istante, di spendere la vita a servizio della verità:
«Siccome non mi fidavo più della mia forza di volontà non ho fatto un voto vero e proprio, ma mi sono impegnato con una promessa: se mi fossi salvato, avrei spesa tutta la vita in funzione di quel versetto del Padre nostro che recita: “Venga il Tuo Regno”. Lì, nella sacca, vedendo i tedeschi e i russi – meglio: i nazisti e i comunisti – che si massacravano così bestialmente tra loro, io pensavo soprattutto al Regno del Padre, cioè a un Regno di amore fraterno tra gli uomini. In seguito mi sono reso conto che ero pressoché inetto ad agire in quell’ordine di cose. Perciò del Regno di Dio (che è il Regno dell’Amore, ma anche della Verità) ho deciso di privilegiare la Verità, ed è in funzione di quella che ho impostato la mia vita» (Paola Scaglione, Parole scolpite. I giorni e l’opera di Eugenio Corti, Ares, Milano 2002, pp. 79-80).
Se quella promessa di darsi da fare per la verità costituisce un emblematico esordio, gli studi d’archivio in corso rivelano che la volontà espressa nella notte di Natale del 1942 è piuttosto la conferma sul campo di una vocazione alla scrittura avvertita con incrollabile chiarezza fin dagli anni del liceo.
Le riflessioni annotate dal giovane mostrano come già a 18 anni dia per acquisita tale vocazione come fine specifico della propria esistenza, riconoscendo in sé delle doti di poesia che mette a servizio di un ideale grande: «Io ho intenzione di scrivere e di compiere un’opera che serva potentemente alla gloria di Dio sulla terra. Io non avrò merito s’intende; ma quest’idea è venuta prendendo in me salde basi, mi pare che sono stato creato soprattutto per questo».
Tale coscienza trova indubbiamente fondamento nell’educazione cristiana ricevuta, ma soprattutto in una naturale sensibilità che, spesso con sofferenza, distingue il futuro romanziere dai suoi familiari e amici. La partecipazione alla ritirata di Russia radica l’intuizione vocazionale nella tragicità dell’esperienza vissuta, nella concretezza della situazione in cui Eugenio Corti si trova a vivere.
Eugenio Corti è tra i pochissimi superstiti del suo settore sul fronte del Don: dei circa 30.000 soldati italiani che componevano il 35° Corpo d’Armata dell’ARMIR riescono a uscire dalla sacca poco più di 4.000 uomini, tre quarti dei quali feriti o congelati non in grado di camminare. L’essere stato restituito alla vita rafforza in lui la coscienza di avere, come tutti, un compito da assolvere nel mondo: il suo è dare testimonianza alla verità attraverso la produzione letteraria.
 Corre l’obbligo di precisare che nel febbraio 1941 gli studenti universitari nati nel 1921, che avevano diritto al rinvio della leva per motivi di studio, vengono chiamati anticipatamente alle armi con la qualifica di «volontari»: Corti, matricola di Giurisprudenza all’Università cattolica di Milano, è tra questi. Ritenendo che, in quel momento storico, il fenomeno più rilevante sia l’esperimento ideologico di realizzazione del comunismo in Unione Sovietica ed essendo convinto che i tedeschi avrebbero vinto la guerra e cancellato ogni traccia di quell’esperimento, vuole rendersi conto della situazione prima che la realtà comunista sia eliminata: per tale ragione, una volta chiamato alle armi, si adopera in ogni modo per essere mandato al fronte russo, per vedere dal vivo, comprendere e condividere attraverso la scrittura quel tentativo di costruire un mondo perfetto estromettendo Dio. Così, nel romanzo maggiore, il suo doppio narrativo, Michele, chiarisce le ragioni che lo spingono in Russia:
Corre l’obbligo di precisare che nel febbraio 1941 gli studenti universitari nati nel 1921, che avevano diritto al rinvio della leva per motivi di studio, vengono chiamati anticipatamente alle armi con la qualifica di «volontari»: Corti, matricola di Giurisprudenza all’Università cattolica di Milano, è tra questi. Ritenendo che, in quel momento storico, il fenomeno più rilevante sia l’esperimento ideologico di realizzazione del comunismo in Unione Sovietica ed essendo convinto che i tedeschi avrebbero vinto la guerra e cancellato ogni traccia di quell’esperimento, vuole rendersi conto della situazione prima che la realtà comunista sia eliminata: per tale ragione, una volta chiamato alle armi, si adopera in ogni modo per essere mandato al fronte russo, per vedere dal vivo, comprendere e condividere attraverso la scrittura quel tentativo di costruire un mondo perfetto estromettendo Dio. Così, nel romanzo maggiore, il suo doppio narrativo, Michele, chiarisce le ragioni che lo spingono in Russia:
«I comunisti hanno tentato un esperimento unico […], una redenzione dell’uomo e della società al di fuori di Cristo e del cristianesimo, anzi contro Cristo. E per fare questo – questo terribile tentativo – si sono isolati dal resto del mondo. Per noi cristiani è importantissimo renderci conto di cos’hanno realmente combinato. […] Voglio parlare con la gente comune russa, con gli operai, i contadini, con tutti. Questa è un’occasione straordinaria, unica. […] Voglio vedere ogni cosa con questi occhi, non voglio limitarmi al sentito dire» (Eugenio Corti, Il cavallo rosso, Ares, Milano 201431, p. 130).
Sin dalle prime intuizioni, dunque, la scrittura cortiana è generata da un intento di rappresentazione realistica e fonda le proprie radici nell’esperienza diretta. Le atrocità vissute nella ritirata confermano l’innata propensione di questo autore al realismo, inteso come scelta narrativa di un soggetto che interpreta da protagonista la realtà e ne scrive. Nasce dalla necessità vitale di testimoniare l’opera prima di Corti, il diario I più non ritornano (1947), un resoconto così asciutto e scarno nella sua tragicità da apparire a tratti una cronaca.
Se in questo testo memorialistico non viene certamente meno l’interesse a comprendere la realtà storica che aveva mosso l’autore a chiedere la destinazione al fronte russo, è tuttavia centrale l’istanza di rappresentazione della propria condizione individuale: la testimonianza, supportata dalla volontà di approfondire razionalmente le vicende personali e collettive, prevale qui su ogni deliberata intenzione letteraria.
In quella drammatica ricerca di una via di salvezza, tra il gelo inimmaginabile dell’inverno russo e i colpi nemici, mentre la morte appare sempre più vicina, il giovane ufficiale, incline per intelligenza, educazione ed esperienza a non fermarsi alle apparenze, coglie l’evidenza di una realtà ben più complessa e profonda rispetto a quanto di essa appaia a uno sguardo superficiale. Pressoché unico tra i testi memorialistici sulla ritirata di Russia, il suo diario, ponendo al centro del narrare la testimonianza personale, ne trascende i confini fino a dilatare lo sguardo sul significato ultimo degli eventi narrati.
Si tratta di un carattere trasversale di ogni sua opera, in una produzione letteraria che indaga nei particolari più minuti e concreti il senso di ogni vicenda umana e della storia nel suo complesso. Proprio questa dimensione esistenziale, che intuisce e razionalizza nella realtà quotidiana il nesso tra il particolare e l’universale, si impone come cifra costitutiva della sua pagina.
Questa impostazione deriva innanzitutto da una marcata connotazione di appartenenza territoriale, che si palesa come sigillo di originalità del suo stile: il modo stesso di essere e di scrivere di Corti è infatti Brianza, intesa più che come luogo fisico come modello di vita, di pensiero, di fede. Di qui una narrazione il cui valore è universale proprio perché nasce da un radicamento deciso in un tempo, in un luogo, in una storia.
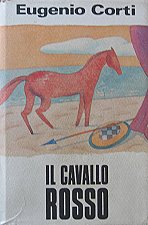 Anche quando le vicende narrate si muovono in mondi diversissimi per struttura umana e mentalità dalla sua terra natale, l’autore le delinea passandole al vaglio della propria appartenenza culturale, che il lettore giunge a percepire come chiave di lettura di tutto ciò che vive nelle pagine cortiane. Tale orientamento si manifesta con particolare evidenza nel romanzo Il cavallo rosso nel quale, sebbene l’opera sia ambientata nella sua terra natale solo per una parte minoritaria, la Brianza assurge naturalmente a punto di origine e di ritorno – fisico o ideale – della storia e dei suoi protagonisti, e il mondo brianteo si delinea come contesto umano e desiderabile per la vita dei singoli e della comunità, garanzia di ordine e possibilità di bellezza offerta a ogni lettore.
Anche quando le vicende narrate si muovono in mondi diversissimi per struttura umana e mentalità dalla sua terra natale, l’autore le delinea passandole al vaglio della propria appartenenza culturale, che il lettore giunge a percepire come chiave di lettura di tutto ciò che vive nelle pagine cortiane. Tale orientamento si manifesta con particolare evidenza nel romanzo Il cavallo rosso nel quale, sebbene l’opera sia ambientata nella sua terra natale solo per una parte minoritaria, la Brianza assurge naturalmente a punto di origine e di ritorno – fisico o ideale – della storia e dei suoi protagonisti, e il mondo brianteo si delinea come contesto umano e desiderabile per la vita dei singoli e della comunità, garanzia di ordine e possibilità di bellezza offerta a ogni lettore.
«Vorrei essere di carta per entrare nel libro», scriveva a Corti una ragazza dopo aver letto questo romanzo. Il mondo bello della Brianza tratteggiato qui è tutt’altro che uno spazio idilliaco esente dal male, ma è uno luogo in cui la pienezza del vivere quotidiano è resa realtà sperimentabile dal riferimento a Dio che segna la vita dei singoli e della comunità. Paradigmatico di tale prospettiva è, nel romanzo capolavoro, il personaggio dello scrittore Michele. Per lui l’arte è «un prodotto spontaneo del nostro popolo, del suo mondo interiore, senza influenze o aggiunte esterne» (Il cavallo rosso, p. 85): per questa ragione, nell’opera di Corti, anche quando la narrazione si sposta fuori dalla terra natale, ogni vicenda è ricondotta alla prospettiva chiarificatrice del sentire brianteo, che consiste, per limitarci all’essenziale, in uno sguardo sulla trascendenza indagata e vissuta con senso pratico e operosità.
Michele, convinto che come per i maestri comacini l’arte si trasmetta di padre in figlio, «sebbene scolpisse pagine anziché pietra», considera la propria vocazione come una continuazione dell’opera di suo padre, uno scalpellino che raffigura drammatici bassorilievi marmorei (Il cavallo rosso, p. 1169)
Analogamente, per Corti la scrittura è un concreto – quasi fisico – portare alla luce il trascendente che fa capolino nel volto sensibile della realtà e ne svela il significato, in una continua e vivificante dialettica tra l’universale e il particolare in cui esso si incarna. Questa radice genera da una parte l’appassionata indagine del particolare che dà vita alla pagina cortiana, dall’altra la presenza di una speranza sempre costruttiva, anche quando il mondo bello e amato raffigurato nel romanzo sembra dissolversi sotto la spinta di una modernità non sempre vivificante. Mai la scrittura scade nel rimpianto o nella nostalgia, perché il cuore della pagina non è il particolare (di cui, pure, lo scrittore avverte pienamente il fascino), ma il suo nesso con l’universale: a questo significato, che nel suo darsi storico si manifesta in un tempo e in un luogo precisi, la parola poetica affida il compito di porsi come modello esemplare offerto al lettore che accolga la sfida di accoglierlo e farlo brillare nei propri giorni.
Con disposizione fattivamente briantea il compito che Corti assegna al proprio lavoro supera i limiti spaziali e temporali della sua vita, in un coinvolgimento del lettore nella costruzione del bene che – a ben vedere – è il compimento di quell’opera «che serva potentemente alla gloria di Dio sulla terra» vagheggiata da ragazzo.
L’esperienza bellica e la riflessione sul contesto storico e culturale del dopoguerra radicano in lui la vocazione di scrittore-testimone, impegnato in una battaglia civile di cui avverte l’urgenza. La consapevolezza di una vocazione ineludibile segna la conclusione del suo romanzo autobiografico sulla guerra di Liberazione in Italia. Riflettendo sul proprio compito e sul nuovo tipo di milizia che avrebbe dovuto affrontare, considera: «“Se non saremo costretti con le armi, a combattere con le idee, con l’azione civile forse? “. Ecco: proprio così! In quel momento avvertii lo Spirito in me, e compresi che non avevo scampo» (Eugenio Corti, Gli ultimi soldati del Re, Ares, Milano 1994, p. 316).
Combattente con la penna per l’intera esistenza, per il portavoce della propria concezione letteraria nel Cavallo rosso sceglie il nome dell’arcangelo verso il quale ha sempre nutrito una speciale devozione: Michele, vale a dire Chi-come-Dio. Se l’arcangelo guerriero lotta per il bene nella trascendenza, Eugenio Corti scrittore-testimone si assume fino in fondo il compito di soldato a servizio della verità nella dimensione storica. Ai suoi lettori lascia il pegno di una tensione a vivere e a raccontare pienamente ogni realtà, in un cammino sospinto da soffi gagliardi di ali d’angelo.
(Paola Scaglione, maggio 2016, LineaTempo)
