L’esperimento comunista
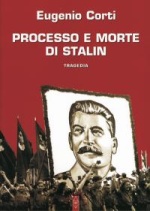 Mio figlio diciottenne – che sta leggendo, stupefatto, L’eskimo in redazione di Michele Brambilla, pubblicato dalle Edizioni Ares – mi domandava l’altro giorno se fosse davvero possibile, negli anni Settanta, orientarsi con qualche sicurezza in mezzo al dilagante conformismo di sinistra, e rendersi conto di come stessero davvero le cose. La mia risposta è stata decisamente affermativa; bastava, gli ho detto, vedere come la pensavano i partiti comunisti italiano e sovietico e – sulla base di questa bussola – dirigersi nella direzione diametralmente opposta.
Mio figlio diciottenne – che sta leggendo, stupefatto, L’eskimo in redazione di Michele Brambilla, pubblicato dalle Edizioni Ares – mi domandava l’altro giorno se fosse davvero possibile, negli anni Settanta, orientarsi con qualche sicurezza in mezzo al dilagante conformismo di sinistra, e rendersi conto di come stessero davvero le cose. La mia risposta è stata decisamente affermativa; bastava, gli ho detto, vedere come la pensavano i partiti comunisti italiano e sovietico e – sulla base di questa bussola – dirigersi nella direzione diametralmente opposta.
Infatti, è sempre stato il “principio-menzogna” (come l’aveva definito Augusto Del Noce in una conferenza pubblicata proprio in queste pagine: cfr SC n. 196, pp. 333 ss.) a guidare ogni mossa comunista a tutti i livelli, locale, nazionale e mondiale; e anche nei rari casi in cui per avventura si potesse rilevare una coincidenza fra la prassi comunista e la verità delle cose, il fatto andava considerato del tutto strumentale. Alla basi delle azioni e della cultura comunista, in altri termini, è sempre stata la famosa “doppiezza”, lucidamente teorizzata da Lenin (“Si deve appoggiare tutto ciò che aiuta ad avanzare, senza farsi noiosi scrupoli morali”; e ancora: “Bisogna ricorrere a tutte le astuzie, ai metodi illegali, alle reticenze, all’occultamento della verità”).
Un atteggiamento mentale come quello da me proposto era peraltro bollato, in quegli anni di piombo (e molte anime belle lo fanno ancora oggi, servendosi di cavillosi e pericolosi “distinguo”), come fascista, antidemocratico, e comunque ispirato a un deprecabile, infantile “anticomunismo viscerale”. Infatti le persone serie e i personaggi alla moda, gli intellettuali e gli opinionisti à la page concedevano largo fido al comunismo, che appariva vincente su tutta la linea e su scala mondiale; e perfino le Brigate rosse – come documenta il libro di Brambilla – erano considerate con qualche benevolenza (“Né con lo Stato né con le BR”, era il motto di un personaggio come Sciascia), e ciò almeno fino al 1977, anno in cui Berlinguer decise che erano invece cattive, perché voleva attuare, con il governo di solidarietà nazionale, il famoso compromesso storico. L’anticomunismo era insomma fuori moda: e l’aggettivo “viscerale” mirava a squalificarlo anche sul piano della logica e della razionalità.
Oggi, a distanza di pochi anni, chiunque può giudicare non solo chi avesse ragione, ma anche l’assoluta fondatezza di un anticomunismo assolutamente intransigente.
Dal dopoguerra in avanti, invero, non c’è stato praticamente alcun argomento o nodo importante – politico, economico o morale – in cui il partito comunista italiano non si sia schierato pesantemente dalla parte sbagliata (culto di Stalin, Patto Atlantico, ingresso nella Nato, guerra di Corea, cosiddetta “legge-truffa”, carri armati in Ungheria, Vietnam e Cambogia, Mao e Castro, invasione della Cecoslovacchia, Etiopia, Angola e Mozambico, Nicaragua, “opposti estremismi”, missili americani in Europa e a Comiso in particolare, divorzio e aborto, tanto per citare a caso): salvo fare marcia indietro, in ritardo e spesso obtorto collo.
Qualcuno aveva capito
Ma – per tornare alla domanda di mio figlio – come si poteva allora giustificare il proprio anticomunismo? Ebbene, gli strumenti non mancavano di certo, anche se occorreva andarseli a cercare quasi sempre al di fuori dei circuiti più noti e diffusi (non era certo sul Corriere della Sera di Giulio Maria Crespi e di Ottone, o sull’Espresso, che si poteva trovare la verità). E, a livello pubblico, parlar male del comunismo voleva dire l’emarginazione, l’impopolarità, il compatimento, soprattutto se ci si permetteva di portare delle prove; nel qual caso scattava l’immediata censura o, peggio ancora, l’autocensura, che stendeva attorno alla voce discorde una cortina di silenzio.
 Uno dei pochi studiosi italiani che rischiarono la faccia – e furono rigorosamente ostracizzati – è stato certamente Eugenio Corti, i cui numerosi interventi sul comunismo sono ora opportunamente ripubblicati in volume (L’esperimento comunista, Edizioni Ares, Milano 1991, pp. 304, L. 28.000).
Uno dei pochi studiosi italiani che rischiarono la faccia – e furono rigorosamente ostracizzati – è stato certamente Eugenio Corti, i cui numerosi interventi sul comunismo sono ora opportunamente ripubblicati in volume (L’esperimento comunista, Edizioni Ares, Milano 1991, pp. 304, L. 28.000).
Si tratta di un libro di grande rilevanza per parecchi motivi: anzitutto per dimostrare ai giovani di oggi – e per ricordare ai ciechi di allora – che anche vent’anni fa c’era chi aveva gli occhi per vedere, e che era possibile difendere la verità delle cose con dignità e con conoscenza di causa.
C’è poi un secondo motivo per cui è importante la pubblicazione di questi studi. Tutti conoscono Corti narratore: I più non ritornano è stato riedito da Mursia l’anno scorso, e Il cavallo rosso (VII edizione) costituisce sicuramente romanzo italiano di più ampio respiro degli ultimi cinquant’anni (e secondo noi di tutto il Novecento).
Ma il Corti studioso attento e informatissimo del fenomeno comunista è noto a pochi, proprio per la situazione di emarginazione in cui la “cultura” dominante lo aveva collocato, non dandogli alcuno spazio nelle sedi di più larga diffusione (va ricordato che alcuni fra i più ampi di questi scritti trovarono ospitalità proprio sulla colonne di Studi cattolici, che da ciò trae motivo di legittimo orgoglio).
I saggi di Corti vengono ora giustamente riproposti nella loro veste originaria, e solo qualche sobria nota di oggi (oltre a un breve studio riassuntivo sul numero delle vittime in Cina) serve a collocarli dell’adeguata prospettiva storica, e a confermare – senza peraltro alcun atteggiamento di trionfalistica rivincita – la loro validità. In essi il fenomeno comunista viene esaminato sia dal punto di vista teorico sia nelle sue drammatiche realizzazioni pratiche: gli orrori del “socialismo reale” sono qui descritti sulla base di una documentazione inoppugnabile e impressionante.
Ritornano così alla nostra memoria – e speriamo che si incidano a fuoco nella mente dei più giovani – alcune delle più immani tragedie del nostro tempo: dallo sterminio dei kulaki alla rivoluzione culturale cinese, dal dramma vietnamita si massacri in Cambogia, in una serie di analisi approfondite e terrificanti, condotte sempre – ed è la caratteristica di questi scritti – con una pietas intensa, non disgiunta tuttavia da una doverosa, vibrante indignazione.
E come non indignarsi, del resto, nel leggere dei massacri dei contadini russi, o nell’apprendere che le vittime del comunismo in Cina ammontano a circa 150 milioni, come si desume da semplici – e prudenziali – calcoli statistici condotti in base al tasso di crescita della popolazione? (Ma il fondamentale libro di Simon Leys sull’argomento non trovo editori né recensori in Italia).
E come non indignarsi ripensando alle falsificazioni e alle deformazioni che in Occidente venivano ammannite, con piena consapevolezza, sulla situazione nel Vietnam e nella Cambogia, mentre le verità era a portata di mano, solo che la cultura dominante – cioè dominata dall’ideologia di sinistra – avesse voluto vederla?
E come non indignarsi, infine – e soprattutto – nel ripercorrere le tappe dell’inevitabile fallimento del comunismo, con tutto il suo corteo di sofferenze, di ingiustizie, di miseria, di sopraffazioni, di corruzione, e nel constatare come questo fallimento sia strettamente consequenziale alle premesse leniniste, le quali contenevano già tutti i successivi tragici sviluppi del sistema? Ma questo non si poteva dire, allora; e studiosi come Solzenicyn e – appunto – Eugenio Corti erano trattati da visionari; finalmente oggi anche il mito di Lenin – del Lenin “tradito” dal cattivo Stalin – comincia a essere preso ufficialmente a picconate (e speriamo di veder presto tradotto il monumentale studio di Richard Pipes sulla Rivoluzione russa, uscito recentemente in America, nel quale si conferma, documenti alla mano, che appunto Lenin è il vero responsabile e il consapevole iniziatore delle spaventose tragedie dei regimi comunisti: fu Lenin, per esempio – e non Stalin – ad affermare che “poco importa che muoiano degli innocenti, se la loro morte è necessaria per salvare la rivoluzione”).
Visione dall’alto
Ma c’è un’altra ragione per cui la pubblicazione del libro di Corti è importante per la cultura italiana (la cultura, questa volta, senza aggettivi): ed è che, nella seconda parte, viene riproposta dopo decenni un’opera teatrale scritta da Corti tra il 1960 e il 1961, e rappresentata a Roma nel 1962 dalla Compagnia Stabile di Diego Fabbri; ma solo per pochi giorni, e solo a Roma, e mai più in seguito, per l’ovvio, soffocante intervento di quella censura ideologica di cui si parlava sopra (la vicenda è raccontata con vigore, ma senza risentimento, nel Cavallo rosso, alle pp. 1158 ss.).
Processo e morte di Stalin è una tragedia, nella quale – come nella tragedia greca – il succedersi degli eventi non si esaurisce nella sua drammatica immediatezza, ma è visto come dall’alto; e si consente così allo spettatore, e al lettore, lo spazio favorevole per una riflessione non superficiale. In questo senso hanno una funzione essenziale sia la severa solennità del linguaggio sia la presenza dei sei cori, che si innestano in maniera non artificiosa nello svolgimento della vicenda e dunque, lungi dall’interromperla, ne sottolineano i punti salienti e ne valorizzano la polivalente ricchezza.
Processo e morte di Stalin è infatti un’opera estremamente sfaccettata, che richiede una lettura a più livelli: in effetti la concreta vicenda (ossia la condanna a morte del tiranno da parte dei suoi più stretti collaboratori, terrorizzati all’idea di essere le prossime vittime, e insieme stanchi per il troppo sangue sparso, ma pronti a spargerne altro) non è fine a sé stessa, ma è sorretta da un attento e sottile approfondimento psicologico dei personaggi: essere umani costruiti a tutto tondo e colti nella loro interiorità più vera, fra i quali naturalmente domina la figura di Stalin, murata in una sospettosa, tragica solitudine imperdonabile ormai dagli affetti e anche solo dalla comprensione degli altri.
Una figura di cui vengono acutamente percepite sia la sanguinaria foga distruttiva sia la stanchezza per le tante stragi, unita alla caparbia volontà di andare, a qualsiasi costo, fino in fondo, per realizzare l’insensata utopia che è la ragione della sua vita: cioè la costruzione del “paradiso” in terra.
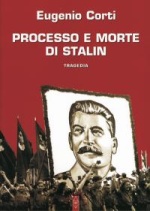 E qui si innesta un altro motivo fondamentale della tragedia: la dimostrazione ineludibile della coerente e logica discendenza di Stalin da Lenin a Marx, e dunque l’inanità di una semplice “destalinizzazione”, la quale non comporti anche il rinnegamento assoluto di Lenin e Marx. È impossibile infatti correggere il sistema comunista senza uscirne radicalmente; è impossibile, in definitiva (e Gorbaciov, oggi, lo sta tristemente verificando), edificare un “comunismo dal volto umano”; anche perché , se si fa leva sull’odio – “il nobile odio proletario”, di cui parlava Lenin – si riesce soltanto a distruggere.
E qui si innesta un altro motivo fondamentale della tragedia: la dimostrazione ineludibile della coerente e logica discendenza di Stalin da Lenin a Marx, e dunque l’inanità di una semplice “destalinizzazione”, la quale non comporti anche il rinnegamento assoluto di Lenin e Marx. È impossibile infatti correggere il sistema comunista senza uscirne radicalmente; è impossibile, in definitiva (e Gorbaciov, oggi, lo sta tristemente verificando), edificare un “comunismo dal volto umano”; anche perché , se si fa leva sull’odio – “il nobile odio proletario”, di cui parlava Lenin – si riesce soltanto a distruggere.
È dato ravvisare, a questo punto, un’ulteriore prospettiva di lettura, perché proprio a partire dal folle tentativo comunista di “trasformare le coscienze” e di costruire l’homo sovieticus – l’autore introduce un’alta e pacata meditazione sulla vera natura dell’uomo, sulla sua non incasellabilità in schemi grettamente materialistici, sul suo sfuggire a qualsiasi inquadramento “scientifico”, che risulta inevitabilmente riduttivo.
Impareggiabile scalpellino
Già da questi brevi cenni appare chiaro che anche in Processo e morte di Stalin sono evidenti le caratteristiche che rendono Eugenio Corti unico nel panorama letterario contemporaneo: la capacità di raccontare con robustezza di stile e penetrante intelligenza storica:; l’attitudine a creare personaggi e caratteri che restano nella memoria; il rigore morale che riesce a distinguere con chiarezza il bene dal male, e dunque sa giudicare, pur senza pronunciare condanne irreversibili; l’umiltà di fondo di chi riflette, ma non pretende di dare lezioni (l’umiltà dello scalpellino, lo “scalpellino-scrittore” di cui si parla nel Cavallo rosso: qualità impareggiabile, oggi che tutti si impancano a maestri, anche se sono poi maestri del nulla); e infine il solido buon senso – tutto lombardo – che sa sdrammatizzare e consente da un lato di restare con i piedi ben piantati per terra, e dall’altro di vedere le cose con un certo distacco, nella fiduciosa convinzione che la Provvidenza la sa più lunga di noi.
È quasi inutile dire, in conclusione, che l’opera di Corti è del tutto controcorrente rispetto alla mentalità di oggi, che, pur dopo il crollo del comunismo, rimane essenzialmente materialista. Ed è quindi incapace di ottimismo e di speranza; ed è incapace, soprattutto, di quel rimorso fecondo e positivo che in linguaggio cristiano si chiama pentimento, conversione, volontà di ricominciare da capo, perché si sa che anche i peggiori peccati possono essere perdonati.
(Paolo De Marchi, 1991, Studi Cattolici)
