Processo e morte di un Edipo che si chiama Stalin
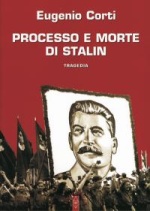 Di Eugenio Corti, già noto per aver quindici anni or sono pubblicato un suo diario di guerra in Russia (I più non ritornano) cui fece seguito I poveri cristi, da lui definito “romanzo-poema-dramma-storia sulla campagna d’Italia”, il Teatro della Cometa diretto da Diego Fabbri ha rappresentato una tragedia in due tempi, Processo e morte di Stalin, la quale ha suscitato pareri discordi. E li ha suscitati nonostante il testo, oltre che da Fabbri (il quale lo ha prescelto per dare inizio a una “Rassegna teatrale dell’opera prima”), fosse avallato da Mario Apollonio. Fabbri aveva scritto nella sua presentazione: “Apre la rassegna un’opera singolarissima che io devo alla segnalazione quanto mai impegnata di quello studioso della storia e del fatto teatrale che è Mario Apollonio. Una tragedia contemporanea; tanto contemporanea che allorché provai a immaginare la realizzazione scenica, fui istintivamente contrastato dal pensiero di dover dar vita scenica a uomini che sono ancora tra noi come Krusciov, Molotov, Malenkov. E devo alla particolare fantasia registica di Orazio Costa se la tragedia ha trovato una sua forma di alta partecipazione scenica che, a mio parere, potrebbe aprire addirittura impensate vie di nuova suggestione allo spettacolo teatrale”.
Di Eugenio Corti, già noto per aver quindici anni or sono pubblicato un suo diario di guerra in Russia (I più non ritornano) cui fece seguito I poveri cristi, da lui definito “romanzo-poema-dramma-storia sulla campagna d’Italia”, il Teatro della Cometa diretto da Diego Fabbri ha rappresentato una tragedia in due tempi, Processo e morte di Stalin, la quale ha suscitato pareri discordi. E li ha suscitati nonostante il testo, oltre che da Fabbri (il quale lo ha prescelto per dare inizio a una “Rassegna teatrale dell’opera prima”), fosse avallato da Mario Apollonio. Fabbri aveva scritto nella sua presentazione: “Apre la rassegna un’opera singolarissima che io devo alla segnalazione quanto mai impegnata di quello studioso della storia e del fatto teatrale che è Mario Apollonio. Una tragedia contemporanea; tanto contemporanea che allorché provai a immaginare la realizzazione scenica, fui istintivamente contrastato dal pensiero di dover dar vita scenica a uomini che sono ancora tra noi come Krusciov, Molotov, Malenkov. E devo alla particolare fantasia registica di Orazio Costa se la tragedia ha trovato una sua forma di alta partecipazione scenica che, a mio parere, potrebbe aprire addirittura impensate vie di nuova suggestione allo spettacolo teatrale”.
Della regia di Costa, e della interpretazione di Carlo D’Angelo e di Elena Da Venezia si dirà più avanti. Al momento basterà notare che si tratta di un allestimento antiveristico, come del resto (né avrebbe potuto accadere altrimenti) è antiveristico il testo del Corti. Collocare sulla scena un personaggio della statura di Stalin e, vicinanza a parte, volerlo cogliere in un momento di crisi (Stalin vittorioso deve scegliere tra due vie: sopprimere i suoi collaboratori o esserne soppresso), quanto dire isolarlo nella solitudine propria d’ogni dittatore e alla quale per un attimo potrebbe porre rimedio la nuora Nadia Mironova (vedova del figlio, suicida in un campo di prigionia tedesco), e per metà della tragedia impegnarlo in un dibattito fra i suoi collaboratori e sottoposti divenuti suoi giudici, e in quel dibattito assegnargli la parte del condannato a morte ma non del soccombente, cioè lasciargli il tempo di asserire che una dittatura collegiale non è possibile e prevedere che fra i suoi giudici (Malenkov, Beria, Krusciov, Kaganovic, Bulganin, Mikolan, Molotov, e Voroscilov) presto si scatenerà la lotta dalla quale sortirà nuovamente un dittatore individuale, vuol dire decidere in partenza di fare opera immaginaria e antistorica almeno per quanto riguarda la plausibilità dei fatti e dei discorsi. E tutto ciò non tanto perché un processo del genere è fantastico, e anche se fosse avvenuto nessuno sarebbe in grado di ricostruirne un resoconto attendibile (così come, storicamente parlando, resterebbe ancora da dimostrare che Stalin meditava davvero una purga di tali dimensioni), ma perché la tragedia ideologica immaginata dal Corti si muove inevitabilmente in funzione di uno schema precostituito. Si aggiunga che in Processo e morte di Stalin lo schema ideologico si inserisce nello schema estetico, sia pure largamente inteso, della tragedia classica.
Se un solo spettatore ne avesse avuto il dubbio, sarebbe bastato a dissiparlo l’epilogo affidato alla parola di Nadia: “Io lascio ad altri le considerazioni di portata troppo vasta perché io le possa capire. Io mi chiedo: come mai il mondo parla ancora oggi delle antiche famiglie dei re mitologici: di Edipo, di Oreste e di Niobe, e dei dolori innumerevoli che loro sopravvennero per avere, con le loro azioni, sfidato la divinità? La nostra famiglia è moderna, è la famiglia di un capo del nostro tempo, di uomini d’oggi. Poiché il grande Stalin, di cui con grande trepidazione un giorno io divenni la nuora, è un uomo d’oggi. E il destino che egli si è fabbricato così modernamente con le sue stesse mani gli ha fatto uccidere la moglie, e il figlio maggiore, e forse anche il suo maestro, sopra ogni essere da lui venerato. E oggi i suoi discepoli, e anche un suo congiunto, uccidono lui. Che sarà poi di Vassilli, il figlio superstite, e dell’infelice Svetlana, cui non il marito, ma il padre viene ora ucciso? Ahimé, quanto incerto e pieno di paurosa oscurità è il nostro futuro!”.
Senza attendere l’epilogo, a chiarire i propositi del Corti contribuivano qua e là accenni per così dire corali, i quali pongono Stalin e i suoi antagonisti su un piano che supera la polemica spicciola a vantaggio di una verità non soltanto politica. La solitudine alla quale è condannato ogni despota assoluto, e la dialettica della tirannia (la quale non può non tener fede alle premesse donde scaturisce) meglio che giustificare il discorso di Stalin, a volte troppo disteso e insistito, esprimono la tragicità di una condizione di oggi in tutto simile alla condizione di ieri e di sempre. Nessun dittatore il quale si trovi nella necessità di difendere la propria azione, può rinunziare ai modi che essa richiede, anche se si era illuso di poterli accantonare. E quanto più la difesa sarà necessaria, tanto più grande sarà la ferocia. Tanto più folle, si può aggiungere, quanto più è lucida. Il tiranno è reo e vittima nello stesso tempo, ribadisce Processo e morte di Stalin, imprigionato in una alternativa la quale, dal momento in cui egli scompare, passa automaticamente ai suoi successori. La pietà tragica dalla quale il Corti si è non senza ingenuità sentito investire è questa. E si capisce che Costa, per meglio esprimerla, si sia attenuto ad una forma spettacolare la quale si avvicina alla così detta lettura più che alla rappresentazione comunemente intesa. Disponendo di attori della capacità e del prestigio di Carlo D’Azeglio (Stalin) e di Elena Da Venezia (Nadia), della cui bravura e castigatezza si sono giovati una ventina di allievi della Accademia Nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” e del centro sperimentale di cinematografia impegnati nello spettacolo, il regista ha evitato l’equivoco che sarebbe potuto derivare da ambientazioni e riferimenti veristici anche minimi (la evocazione tende a misurarsi sulla distanza del tempo, o addirittura ad astrarsene) e contemporaneamente si è misurato in un esperimento che da noi solitamente è considerato come cosa nella quale non occorra impegnarsi a fondo, laddove invece esige particolare rigore.
Se dalla rappresentazione di Processo e morte di Stalin emerge una contraddizione palese, la ragione sta in questo: che mentre da una parte si auspica e si sollecita la tragedia d’oggi, quando poi la tragedia è tentata, al momento di sperimentarla si studia il modo di estrarla dalla attualità e trasportarla in una dimensione più grande. La contraddizione non è di natura drammaturgica. Deriva dal fatto che i contemporanei non sono mai tragici, nemmeno quando al loro nome sono legate tragedie immani.
(Raul Radice, 15/04/61, L’Europeo)
